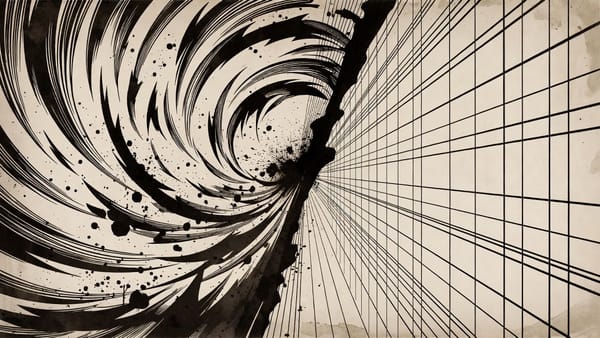Tra la torre d'avorio e il festival pop

Gli intellettuali sui social
Abstract. Nel tempo dei social, l’intellettuale è preso in una trappola: se semplifica per essere pop diventa impreciso, se resta rigoroso appare elitario, se tace è accusato di ritirarsi. L’errore non è più occasione di confronto, ma pretesto di delegittimazione. Senza comprensione condivisa, la discussione pubblica si riduce a tifo e pulsione.
1. Esporsi
Un tempo diventare un intellettuale di riferimento poteva essere gratificante. Oggi, nell’epoca dei social — che spesso sono anche il luogo da cui nascono visibilità e fama — intelligenza e cultura funzionano come un bersaglio.
Non perché gli intellettuali siano i soli esposti: chiunque diventi un profilo pubblico, sui social, è esposto. Ma per un intellettuale l’esposizione assume una forma particolare. Non esiste una posizione che non lo metta in difficoltà.
Chi ha competenza viene messo sullo stesso piano di chi non ha né cultura né responsabilità pubblica. Incensato e insieme incenerito. I pregi vengono esaltati fino alla caricatura; i difetti, anche minimi, mai perdonati. Intorno si formano tifoserie: se non si va nel merito, ci si attacca alla sensazione.
Pallone gonfiato, professorone, tuttologo, distante dal mondo.
Si viene interpellati su tutto e poi accusati, nello stesso movimento, di sconfinare, di uscire dal proprio campo. Qualunque posizione è potenzialmente sbagliata, ma non sempre — come sarebbe giusto — nel merito: se rispondi sei arrogante. Se taci, pavido. Se spieghi, paternalista. Se semplifichi, superficiale.
2. L’errore come metodo, non come colpa
Va detto: gli intellettuali sbagliano. Ed è un loro diritto.
È esattamente per questo che esiste la cultura. Il sapere nasce dal confronto delle opinioni, dalla revisione, dall’errore corretto pubblicamente. L’errore non è un incidente: è una funzione.
Per secoli abbiamo creduto che Maria Antonietta avesse davvero detto «che mangino le brioches». Abbiamo ripetuto che Cartagine fosse stata cosparsa di sale alla fine delle guerre puniche. Falsità storiche sedimentate, tramandate anche da studiosi autorevolissimi.
Gli intellettuali fanno anche questo: correggono errori trasmessi da altri, a volte da altri molto più illustri di loro. E nel farlo sbagliano a loro volta. Non è una colpa: è il metodo stesso del sapere che avanza per correzioni successive.
E questo vale anche quando non sbagliano nulla.
Ma quando sbagliano — non qualcosa di grave, non una menzogna o un abuso, solo un errore — allora scatta il godimento. Lo sbugiardamento diventa uno sport. L’errore viene amplificato, decontestualizzato, isolato, collegato retroattivamente a tutte le “cazzate” che si dice abbiano detto.
“Era ora”, “finalmente”, “si è visto chi è davvero”. Una piccola festa sadica.
E intorno partono le tifoserie: non per discutere, ma per menare. Una rissa senza costrutto.
Questo non significa che l’intellettuale non debba essere criticato quando sbaglia: contestare nel merito è parte del gioco.
Qui però non si discute, si festeggia il fallo. L’errore diventa rivalsa, non occasione di chiarimento. E spesso viene stiracchiato fino a diventare un capo d’accusa universale, capace di delegittimare retroattivamente anche ciò che errore non era.
3. Il codice dei social e il corto circuito politico
Qui entra in gioco il nodo specifico dei social.
Se un intellettuale vuole essere pop, deve accettare il codice non scritto del mezzo.
Semplificazione, velocità, slogan, comunicazione empatica, salti logici, slittamenti semantici. Spesso improvvisazione ed estemporaneità. Non perché sia superficiale, ma perché il mezzo funziona così. Scrivere un saggio è una cosa, scrivere su un giornale un’altra, scrivere sui social un’altra ancora.
Tempi, spazi, linguaggi, codici e capacità medie di comprensione sono radicalmente diversi.
Per stare lì dentro devi perdere precisione. È inevitabile.
Ma l’imprecisione, per un intellettuale, non viene mai trattata come una necessità comunicativa: viene trattata come una colpa.
C’è però un effetto ulteriore, più sottile.
In un mondo così semplificato, il criterio per distinguere gli intellettuali di razza da quelli banalotti — semplici non per scelta, ma per limite — diventa molto più sfumato. Quando tutto viene ridotto a slogan, tempi rapidi e frasi ad effetto, chi semplifica per tradurre e chi semplifica perché non sa andare oltre finiscono per assomigliarsi. La differenza tra profondità e povertà di pensiero diventa opaca, spesso invisibile.
Questo se l’intellettuale si fa pop.
Se non diventa pop, il problema non si risolve. Appare fuori luogo. Elitario. Incomprensibile. Uno che parla solo ai suoi.
Se poi decide di non partecipare affatto ai social, la diagnosi è pronta: torre d’avorio. Chierico che si sottrae. Anche il silenzio diventa un’accusa.
In altre parole: qualunque cosa faccia, sbaglia.
Non perché gli intellettuali siano perseguitati o speciali, ma perché il loro lavoro entra in conflitto con il funzionamento dello spazio pubblico digitale.
I social non sono un medium “basso”. Sono un medium ostile alla precisione.
Non impediscono di parlare, ma rendono difficilissimo costruire un orizzonte comune di comprensione. Tutto è immediato, reattivo, frammentato. La velocità sostituisce il senso, l’emozione sostituisce la definizione.
E questo non è solo un problema culturale. È un problema politico.
Una democrazia senza un orizzonte condiviso di comprensione non discute: reagisce. Non chiarisce i concetti: li usa come armi. È la dittatura delle pulsioni.
Socrate lo aveva capito all’inizio di tutto. Prima di discutere se qualcosa è giusto o sbagliato, bisogna sapere che cos’è. Il ti estì. Senza una definizione comune, anche provvisoria, anche contestabile, il dialogo si dissolve e resta solo il rumore.
In questo clima nasce anche una forma diffusa di autocensura.
Una parte enorme del lavoro intellettuale oggi non consiste più nel capire meglio le cose, ma nel calcolare come dirle, se dirle, quando dirle, e soprattutto come evitare che una semplificazione necessaria venga trasformata in una condanna da parte di un qualsiasi analfabeta funzionale. Non un critico, non un interlocutore: chiunque disponga di indignazione e tastiera.
E sì, lo so benissimo che quello che sto scrivendo è fuori luogo.
Questo pippone non è da Facebook. Non è il formato giusto. Né il linguaggio. Né il tempo.
Ma so anche che tre di voi lo leggeranno fino in fondo. E mi sembra già molto. Anzi: mi sembra un dono. Forse persino un miracolo.