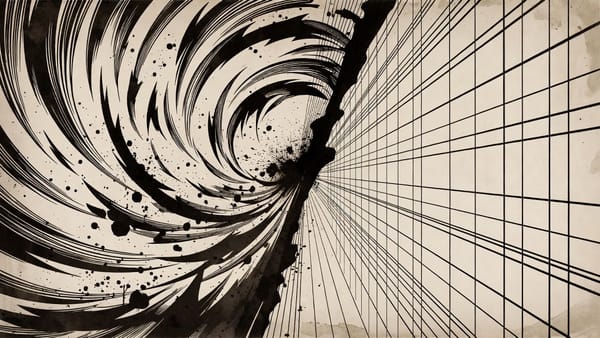In Italia in futuro è passato di moda

Riforme, paure e restaurazioni mascherate
L’Italia, che ama raccontarsi come patria della creatività e del genio, è in realtà un paese profondamente conservatore. E pauroso. Non per scelta ideologica, ma per una difficoltà strutturale a stare nel tempo. Il futuro viene percepito come un’eccedenza: qualcosa che chiede troppo, che altera gli assetti, che obbliga a scegliere. Meglio allora ridurlo, sospenderlo, rinviarlo. Tenerlo a distanza. Si ha la netta impressione che la creatività sia celebrata come mito identitario purché resti decorativa; il genio come eccezione folklorica purché non diventi sistema.
La sinistra italiana è da decenni conservatrice e difensiva perché abita un presente continuo. Non progetta: amministra. Non anticipa: stabilizza. Vive di equilibri instabili ma riconoscibili, e li scambia per responsabilità. La tecnologia, in questo quadro, non è una possibilità da governare ma una forza ontologicamente sospetta: accelera, disordina, toglie appigli morali. Da qui l’istinto a rallentare tutto, a normare prima di capire, a trattare ogni salto come una colpa. È un conservatorismo da sopravvivenza, non da ideologia: un’ostrica verghiana che si chiude per istinto.
La destra italiana non è però innovatrice, come molti potrebbero pensare. È conservatrice in modo speculare. Anche qui il futuro è una minaccia, ma la risposta è diversa: non il rifugio nel presente, bensì il ripiegamento in ciò che è già stato. Quando può, si appoggia al passato — famiglia, ordine, morali sedimentate. Quando questo passato non regge più, resta il denaro. Non come mezzo, ma come garanzia. In entrambi i casi il futuro non è uno spazio di possibilità, ma un agente di contaminazione.
È proprio questa concordanza sulla paura del futuro che spiega due fenomeni solo apparentemente distanti: il fuoco di paglia di Renzi, presentatosi come modernizzatore salvo poi smentirsi; e la convivenza, nel Movimento 5 Stelle delle origini, prima di Conte, di revanchismi tanto di destra quanto di sinistra.
Il risultato è un paese che tende a dire no per riflesso quando il cambiamento apre davvero il futuro, quando chiede di rischiare, quando sposta equilibri e identità. Ma l’Italia sa dire sì, eccome. Solo che spesso lo dice a riforme che hanno l’aria della novità e la sostanza della restaurazione: cambiamenti che promettono di mettere ordine, di semplificare, di riportare il tempo a una forma già conosciuta.
Così il sì finisce per assomigliare a un no ancora più pronunciato: un sì al ritorno al passato.
A 56 anni queste cose non le ho lette: le ho viste succedere. Le ho attraversate da elettore, da cittadino, da lavoratore.
Da quando ho diritto di voto, la parola riforma ha cambiato segno. Non indica più un avanzamento, ma una perdita di struttura. Nella mia esperienza politica — trasversale, non ideologica — la maggior parte delle riforme, di destra e soprattutto di sinistra, ha peggiorato la qualità democratica e la tenuta del sistema paese. Non per malafede, ma per cecità temporale.
Il primo passaggio decisivo sono stati i referendum voluti da Mario Segni. Dovevano sbloccare il sistema. Hanno demolito la rappresentanza proporzionale senza costruire una vera cultura maggioritaria e inaugurato un decisionismo povero di mediazioni ma ricco di personalizzazione. I partiti si sono svuotati, il Parlamento ha perso centralità, senza che emergessero istituzioni alternative capaci di reggere il peso della decisione. Non più governabilità, ma fragilità.
La stagione delle riforme amministrative di Franco Bassanini ha seguito la stessa logica. Doveva rendere lo Stato più efficiente. Ha frammentato le responsabilità e introdotto una managerializzazione che ha indebolito la cultura istituzionale. Il diritto è stato sostituito dalla procedura, la funzione dalla performance.
La scuola, figlia di quella stagione, ne ha ereditato l’instabilità: autonomia senza risorse, valutazione senza senso condiviso, riforme continue che hanno corroso continuità e autorevolezza. Il danno più profondo, però, è stato simbolico: i docenti declassati da professionisti a impiegati, da educatori a fornitori di servizio.
La riforma delle fondazioni bancarie ha prodotto esiti analoghi. Doveva separare politica e credito; ha creato centri di potere opachi, difficilmente controllabili, sottratti tanto al mercato quanto alla responsabilità democratica. In parallelo ha accelerato una finanziarizzazione delle scelte pubbliche che ha svuotato la politica senza sostituirla con un controllo razionale.
La riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana ha mostrato con chiarezza l’assenza di una visione sistemica. Ha prodotto un conflitto permanente tra Stato e Regioni e una crescente disuguaglianza territoriale. Diritti fondamentali come sanità e istruzione sono diventati variabili geografiche. Non più cittadini, ma residenti.
A questo si sono aggiunte le riforme elettorali, sempre provvisorie e mai stabilizzate. Il legame tra elettori ed eletti si è indebolito, le responsabilità politiche si sono opacizzate. La democrazia è rimasta un cantiere senza progetto.
Lo stesso è accaduto per lavoro e pensioni. Riforme presentate come inevitabili, sempre in nome del futuro, ma applicate come amputazioni nel presente. Precarizzazione senza libertà da un lato, slittamento continuo dell’età pensionabile dall’altro. Il patto intergenerazionale si è consumato senza essere sostituito.
A questo punto mi sono chiesto se il problema non fossi io. Se non avessi sviluppato una diffidenza pregiudiziale verso l’idea stessa di riforma. Ma la risposta è no. Non sono le riforme in quanto tali a essermi diventate sospette. È il loro rapporto col tempo.
Benedico le riforme del lavoro e della scuola degli anni Sessanta, perché ampliavano diritti e aprivano possibilità. Benedico la Legge 194, perché ha restituito alle donne sovranità sul proprio corpo. Benedico la riforma Vassalli della giustizia, perché ha spostato il baricentro dal castigo alla garanzia. Benedico anche la riforma Basaglia, la Legge 180, perché ha chiuso i manicomi e affermato un principio radicale: la malattia mentale non sospende la dignità, e la cura non può coincidere con la segregazione. E guardo con cautela anche alla Legge Mammì, che almeno tentava di dare una cornice normativa a un fatto già esistente.
Queste riforme avevano un tratto comune: non nascevano dalla paura del futuro, ma dalla sua accettazione. Non difendevano il presente: lo trasformavano. Chiedevano conflitto, ma offrivano orizzonte.
Al contrario, le riforme bipartisan sull’immunità parlamentare e sul finanziamento pubblico ai partiti hanno scelto la scorciatoia sbagliata. Hanno confuso la garanzia con il privilegio e la riforma con la punizione. Il Parlamento è diventato più vulnerabile, i partiti più poveri e dipendenti, la politica meno autonoma.
A questo quadro si aggiunge la Legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita: una riforma nata per contenere, non per governare. È la legge che disciplina l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita imponendo limiti rigidi e un impianto etico difensivo, più orientato a porre divieti che a regolare una pratica già presente nella società. Il risultato è stato duplice: una norma rapidamente corretta dalla giurisprudenza e una politica che ha preferito il confine simbolico alla responsabilità di pensare il nuovo. Non un progetto, ma una difesa.
Messe insieme, queste riforme raccontano la stessa incapacità: pensare il tempo lungo. Si è corretto senza immaginare, si è smontato senza costruire, si è chiesto adattamento senza offrire senso.
È anche per questo che l’Italia resta immobile. Non perché non cambi, ma perché cambia male. Senza desiderio, senza visione, senza fiducia. E intanto il tempo passa. Invecchiamo. Non solo demograficamente, ma mentalmente. Si entra nella vita con una prudenza precoce, con una postura già stanca. Si nasce quasi già vecchi. Il futuro viene sempre spostato più in là. C’è sempre tempo. Purché non sia adesso.