Il potere come destino
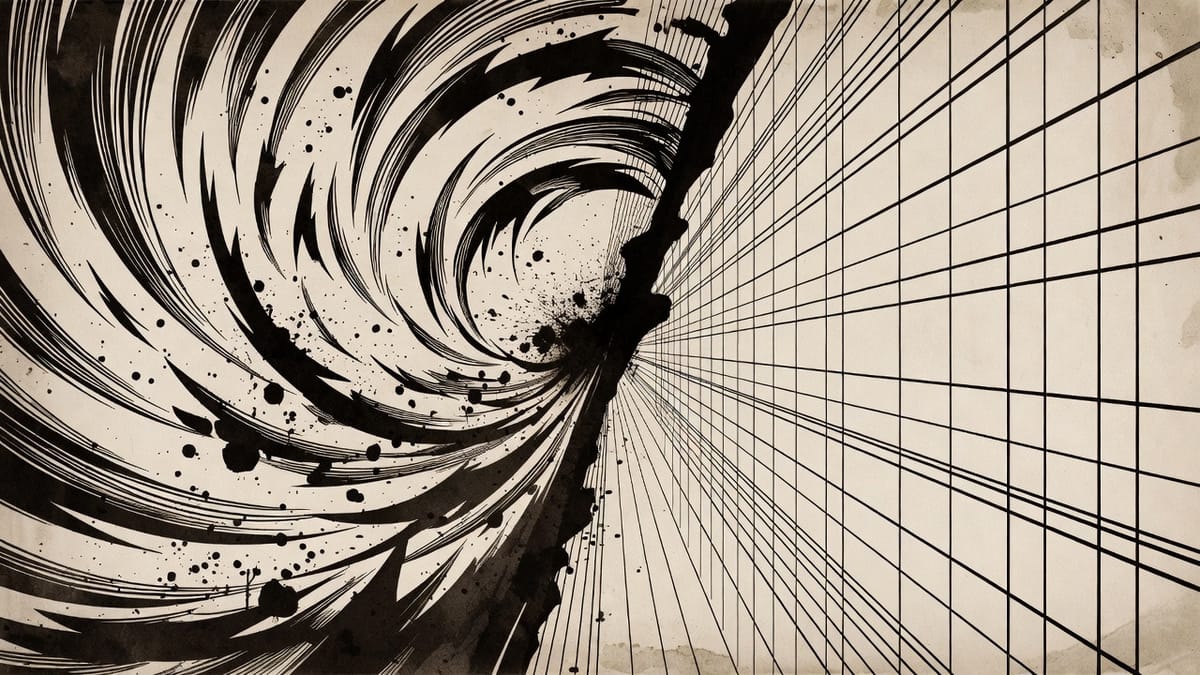
Aporia, caos e sottomissione nell'orizzonte archeontologico
20 febbraio 2026
Il potere come destino: aporia, caos e sottomissione nell'orizzonte archeontologico
I. La struttura del desiderio: contro l'eudaimonismo come teleologia normativa
Prima di procedere, è necessario fissare con precisione la triade fondamentale dell'Archeontologia, onde evitare ogni ambiguità operativa: Possibilità — Necessità — Realtà (o Creazione, termine che userò come sinonimo dichiarato di Realtà nella misura in cui indica il momento in cui il possibile si determina nel concreto). La Possibilità è il momento inaugurale, l'apertura strutturale dell'ente verso ciò che non è ancora; la Necessità è il vincolo interno che dà forma a tale apertura senza annullarla; la Realtà/Creazione è l'effetto prodotto, il mondo modificato. Ogni momento del discorso che segue andrà letto in riferimento a questa sequenza.
La Necessità va intesa su due piani complementari: come struttura formale interna all'ente — il vincolo che dà forma alla Possibilità senza annullarla —, e come vincolo operativo storicamente concretizzato attraverso le sedimentazioni che la Realtà produce retroattivamente sulle possibilità successive. I due piani non si contraddicono: il secondo è la forma in cui il primo si manifesta nell'azione effettiva.
Detto questo, si può affrontare la questione centrale. La tradizione filosofica occidentale — da Aristotele a Mill, passando per la teologia morale cristiana e le varianti utilitaristiche della modernità — ha edificato sull'eudaimonia, o su un suo surrogato, il telos della condotta umana. L'uomo, si è ripetuto con un'ostinazione che merita essa stessa analisi genealogica, tende alla felicità. Non nego che gli uomini cerchino anche piacere, legami affettivi, quiete, contemplazione. Sostengo però che, a livello strutturale, tutte queste istanze dipendono da qualcosa di più elementare e più perturbante: la ricerca del potere. Non il potere inteso come mera dominazione coercitiva su altri soggetti — che chiamerò d'ora in poi dominazione per evitare equivoci —, bensì il potere inteso come efficacia trasformativa: la capacità di produrre effetti nel mondo, di fare differenza nella tessitura dell'esistente, di non essere soltanto effetto ma causa. Questa capacità la chiamerò, con riferimento esplicito a Spinoza ma con autonomia rispetto a lui, potenza. L'affermazione forte dell'Archeontologia è dunque: ciò che gli uomini cercano strutturalmente non è la felicità come stato, ma la potenza come condizione ontologica del proprio dispiegamento.
Occorre però già qui anticipare una distinzione che si rivelerà decisiva. Sul piano ontologico, la potenza non nasce da una mancanza: è — come Spinoza aveva visto con precisione nel concetto di conatus ("quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur", Ethica, III, prop. 6) — pura autoaffermazione, sovrabbondanza che si espande senza che alla sua radice ci sia alcuna privazione. Gilles Deleuze aveva insistito su questo punto nel suo commento a Spinoza: la potenza è pienezza che si afferma, non vuoto che cerca di colmarsi; è positio, non privatio. È opportuno però precisare, per non esporsi a una lettura quantitativistica, che "espansione" non significa crescita illimitata in senso numerico, ma incremento di adeguatezza causale: più la potenza agisce secondo la propria natura — più cause adeguate produce, meno è ridotta a effetto passivo di cause esterne — più si espande nel senso spinozianamente rigoroso del termine. A questo livello, la Possibilità archeontologica e il conatus spinoziano convergono: entrambi descrivono la potenza come eccedenza rispetto alla Realtà data, un impulso espansivo che non richiede alcuno scandalo per giustificarsi.
Sul piano fenomenologico-esistenziale, tuttavia, accade qualcosa di diverso. Il modo finito in Spinoza — e l'uomo nell'Archeontologia — non è mai pienamente causa sui: è sempre anche determinato da cause esterne, sempre parzialmente passivo (passiones). Il conatus del modo finito non si esercita mai in campo aperto: incontra resistenza, compressione, limiti che non ha scelto. Ed è precisamente in questo incontro tra la sovrabbondanza della potenza e i vincoli non scelti che nasce ciò che chiamo "scandalo": non come condizione costitutiva del desiderio in senso ontologico, ma come la qualità fenomenologica con cui la finitezza umana si avverte nel suo urto con la Necessità non scelta. Lo scandalo non fonda il desiderio di potenza — che ha radice in sovrabbondanza — ma descrive come quel desiderio si sperimenta, nell'umano concreto, quando incontra il proprio limite. La fonte è affermazione; la forma vissuta è resistenza; e la resistenza vissuta dall'interno da un ente autocosciente è scandalo.
Un ente che non incontrasse mai vincoli strutturali alla propria azione — figura controfattuale, non descrizione ontologica di un ente reale — non sperimenterebbe lo scandalo del limite: ma tale ente non sarebbe finito nel senso fenomenologico qui in gioco, e dunque non sarebbe umano nel senso che a questo saggio interessa. L'Archeontologia descrive l'umano concreto nella sua tensione tra sovrabbondanza ontologica e finitezza vissuta: e in quell'umano concreto la potenza si avverte sempre come desiderio che urta, mai come pura espansione incontrastata.
Elias Canetti, nel monumentale Masse und Macht (1960), aveva analizzato la sopravvivenza come momento parossistico dell'affermazione di sé contro il mondo: sopravvivere al nemico, al pari, persino all'amico, costituisce la forma più elementare della potenza, la sua radice biologica e simbolica insieme (cfr. la sezione sul "sopravvissuto"). Ma Canetti si muove sul piano antropologico-politico dell'esperienza del potere — ne descrive le forme, le intensità, le strutture di massa —, senza esplicitarne la struttura ontologica sottostante. L'Archeontologia compie questo passaggio ulteriore: non descrive come il potere si manifesta, ma mostra perché un ente finito che si sa tale non può non cercarlo, radicandolo nella sequenza Possibilità-Necessità-Realtà e nella tensione tra sovrabbondanza ontologica e finitezza fenomenologica.
Friedrich Nietzsche aveva avanzato l'ipotesi del Wille zur Macht come principio interpretativo della vita e dei valori — non come psicologia umana, ma come grammatica del vivente in quanto tale (Jenseits von Gut und Böse, 1886, § 259; Zur Genealogie der Moral, 1887, II, § 12). Il rischio nietzscheano, tuttavia, non è tanto quello di "naturalizzare" il potere — formula troppo generica in un autore che ha sistematicamente destabilizzato la distinzione natura/cultura — quanto quello di generalizzarlo fino a perdere il tratto propriamente antropologico: il limite vissuto come scandalo. In Nietzsche la volontà di potenza vale per la vita, per la materia, per i valori stessi; nell'Archeontologia essa vale specificamente per un ente che si sa finito e che nel riconoscimento della propria finitezza — cioè nell'urto tra la sovrabbondanza della Possibilità e la Necessità non scelta — trova il motore esistenziale dell'impulso a trascendersi. L'aggiunta determinante non è cosmologica ma fenomenologica: è il come si avverte il limite, non il mero fatto che vi sia un limite.
II. L'aporia fondamentale: il potere assoluto come caos ontologico-operativo
Definisco qui con precisione il concetto in gioco. Il "potere assoluto" di cui si parlerà in questa sezione non è figura della dominazione — la coercizione su altri soggetti —, bensì figura limite della potenza: indica una potenza che non possa essere condizionata nemmeno dai propri effetti, immune da qualsiasi sedimentazione strutturale delle proprie azioni. È questa la definizione rigorosa, e da essa si ricava l'aporia.
Ogni atto di potenza produce effetti. È essenziale però distinguere tra conseguenze locali — effetti circoscrivibili, reversibili, eventualmente cancellabili nella loro traccia immediata — e sedimentazioni strutturali: modificazioni del tessuto del reale che rientrano come condizioni nella situazione in cui il soggetto agente dovrà esercitare il prossimo atto. Un tiranno può cancellare un decreto, ma non può cancellare il fatto che i sudditi abbiano appreso che i decreti si cancellano. Un magnate può dismettere un'azienda, ma non può dismettere il fatto che i mercati abbiano registrato quel gesto come segnale. Le sedimentazioni strutturali sono irreversibili non perché producano effetti fisici indelebili, ma perché riorganizzano le aspettative, le istituzioni, i rapporti di forza — cioè le condizioni di possibilità degli atti successivi.
Il potere assoluto, così definito, è ontologicamente vuoto — e qui il termine va inteso in senso preciso, interno alla triade archeontologica. Una potenza immune dalle proprie sedimentazioni strutturali sarebbe Possibilità che non si aggancia mai nella Realtà: produrrebbe gesti senza conseguenza strutturale, cioè non produrrebbe Realtà nel senso della triade. Sarebbe Possibilità priva del momento della Necessità che la forma — pura virtualità indifferenziata, che non diventa mai qualcosa di determinato. Per non essere condizionato nemmeno dalle proprie sedimentazioni strutturali, il potere assoluto dovrebbe in sostanza non agire strutturalmente: ma in questo caso non è potenza attuabile: è potenza solo virtuale, impotenza operativa — Possibilità che non riesce a diventare Realtà e che quindi non è, in senso archeontologico, potenza in atto. Il potere assoluto in atto produce pertanto ciò che chiamo caos ontologico-operativo: non caos entropico in senso fisico, né disordine psicologico, ma il collasso della coerenza interna di un'azione che, nel tentare di non essere mai condizionata, non riesce mai a consolidarsi in forma.
Thomas Hobbes, in Leviathan (1651, cap. XIII), aveva già visto che lo stato di natura — in cui ogni uomo esercita potere su ogni altro senza limitazione giuridica — non produce onnipotenza ma la guerra di tutti contro tutti, negazione pratica di qualsiasi potere stabile. La soluzione hobbesiana — il trasferimento della competenza decisionale sovrana a un terzo, assoluto non in senso metafisico ma nella sua incontestabilità giuridica all'interno dell'ordine civile — è già un riconoscimento implicito che la potenza non si esercita senza essere limitata dalla forma stessa che le dà efficacia. Carl Schmitt, in Politische Theologie (1922, cap. I), aveva radicalizzato questo punto identificando nel sovrano colui che decide nello stato di eccezione. Ma l'eccezione non è un evento che si esaurisce: è una struttura latente dell'ordine, sempre potenzialmente riattivabile. La sovranità non sparisce quando l'eccezione si normalizza; si istituzionalizza — ma senza perdere la personalità della decisione, che resta sempre in linea di principio attivabile: si incardina piuttosto in apparati e procedure che la mediano, trasformando la potenza carismatica in funzione condizionata dall'architettura istituzionale che essa stessa ha generato. Anche qui il meccanismo è lo stesso: il potere produce ordine; l'ordine condiziona il potere.
Georges Bataille, con il concetto di dépense (La notion de dépense, 1933), aveva intuito la logica della spesa senza ritorno come dimensione costitutiva dell'esperienza umana. Il mio uso di questo concetto è tuttavia esclusivamente strutturale, non esperienziale: non sto descrivendo la fenomenologia del sacro o dell'eccesso, ma indicando che la stessa struttura — dispendio senza capitalizzazione — innerva il potere assoluto come aporia. La differenza rispetto a Bataille sta nel contesto: là è una fenomenologia del soggetto alle soglie del limite; qui è un'analisi dell'architettura interna della volontà di dominio.
III. La beatitudine come sospensione della potenza trasformativa
Non è senza significato che le grandi tradizioni di pensiero abbiano concepito la beatitudine come forma di compimento che si sottrae alla logica della potenza trasformativa. Dante, nella Commedia, descrive la condizione dei beati come totale docilità nei confronti della luce divina: la loro perfezione non è definita dall'efficacia trasformativa sul mondo sublunare, ma dalla perfetta coincidenza con l'ordine provvidenziale (cfr. Paradiso, III: "E 'n la sua voluntade è nostra pace"). I beati non cessano di essere cause — la tradizione tomistica li ammette all'intercessione e alla causalità seconda —, ma cessano di essere cause autonome che cercano di modificare il mondo secondo una volontà propria. La beatitudine dantesca è la pace di chi ha integrato la propria Possibilità nella Necessità divina senza più esperire quella integrazione come limitazione.
La tradizione epicurea e pirroniana costruisce il proprio ideale attorno all'atarassia — l'imperturbabilità — e all'aponia — l'assenza di dolore fisico —, non intese come indifferenza cinica bensì come riduzione disciplinata dei desideri a ciò che è necessario e naturale (Epicuro, Epistola a Meneceo, 127-128). Il saggio epicureo non cerca di trasformare il mondo: si ritira dalla competizione per la dominazione e coltiva, nel limite del giardino privato, forme di esistenza compatibili con la stabilità interiore. Diversa e non confondibile è la posizione stoica, per la quale l'azione nel mondo e il ruolo civile rimangono doveri del saggio: escludere gli Stoici da questo quadro è necessario per non appiattire differenze che segnano le tradizioni.
Più complessa, e più feconda per il nostro discorso, è la Gelassenheit heideggeriana — il lasciar-essere, il Seinlassen — che Heidegger riprende da Meister Eckhart (Reden der Unterscheidung, ca. 1294-98) reinterpretandola come modo d'essere non tecnico, non appropriativo, nei confronti dell'essere (Gelassenheit, 1959). Non si tratta di rinuncia all'azione né di estinzione del rapporto col mondo, ma della sua trasformazione qualitativa: non imporre alle cose il proprio progetto, ma aprirsi alla loro presenza. La Gelassenheit è pertanto una forma trasformata dell'agire — non la pace come estinzione dell'istanza trasformativa, ma la pace come modo diverso di abitarla: distinzione che sarà decisiva in chiusura, dove si mostrerà che essa custodisce un paradosso irrisolvibile ma illuminante.
Il tratto comune a queste tre figure — non la loro identità — è la sospensione della volontà di produrre sedimentazioni strutturali nel mondo secondo un progetto di dominazione. Tutte e tre riconoscono, seppure da angolazioni irriducibili l'una all'altra, che il compimento dell'uomo non risiede nel dispiegamento illimitato della propria potenza trasformativa, ma in una forma di rapporto con la Realtà che trasforma la Possibilità senza cercare di saturare la Necessità.
IV. La vittima del proprio potere: dominazione, impunità ed esiti non intenzionali
Se il potere assoluto è aporetico, e se le grandi tradizioni della saggezza ne hanno riconosciuto il limite cercando vie d'uscita, perché gli uomini continuano a cercare la dominazione con tale ostinazione? La risposta è nella struttura dell'impunità: chi domina, nel momento in cui esercita la propria dominazione senza incontrare resistenza, non percepisce le sedimentazioni strutturali che sta producendo. L'impunità non è soltanto uno stato giuridico: è uno stato cognitivo e ontologico. Il tiranno, il magnate, il sovrano assoluto — e i loro emuli ad ogni livello della gerarchia sociale — agiscono in una temporalità contratta, in cui l'effetto immediato dell'azione oscura le sue conseguenze strutturali. Ciò che si accumula invisibilmente è il sistema di condizioni che quelle stesse azioni hanno sedimentato e che si riverseranno sul soggetto in forme inattese.
Hannah Arendt, in On Violence (1970, cap. II), aveva distinto con precisione tra potere (power) e violenza (violence): il potere autentico è sempre relazionale e collettivo, esiste finché le persone agiscono insieme; la violenza è strumentale e individuale, e può sospendere o sostituire temporaneamente il potere, ma al prezzo di eroderlo — poiché si fonda sulla coercizione, non sul consenso che solo fonda la durabilità. Il tiranno non è il più potente: è colui che ha sostituito la potenza condivisa con la violenza strumentale, e che pertanto è strutturalmente solo e strutturalmente fragile.
L'Archeontologia aggiunge però una dimensione che Arendt non esplora: non è solo il tiranno a essere vittima del proprio potere, ma ogni soggetto che strutturalmente lo persegue. Chiamo questo meccanismo eterogenesi delle condizioni: le azioni umane, perseguendo fini particolari, producono esiti non intenzionali che nessuno aveva progettato — e che, diversamente dalla provvidenza vichiana (Scienza nuova, 1744, Lib. I), non convergono necessariamente in ordine, ma in un sistema di vincoli autoprodotti. Chi ha costruito un impero è prigioniero dell'impero; chi ha eliminato ogni opposizione è prigioniero della propria paranoia; chi ha istituito un ruolo di dominazione è prigioniero del ruolo. La vittoria della dominazione porta con sé la necessità di difenderla, amministrarla, giustificarla: e in ciascuna di queste operazioni il potere originariamente libero si cristallizza in obbligo, in identità che non può essere abbandonata senza perdere tutto ciò che la dominazione aveva conquistato.
V. La sottomissione come atto di potenza: flusso, destino e criterio archeontologico
Il territorio più sottile e paradossale è quello in cui si deve pensare la sottomissione volontaria non come negazione della potenza ma come sua forma peculiare. Hegel, nella dialettica servo-signore della Phänomenologie des Geistes (1807, cap. IV), aveva mostrato che il signore — colui che sembra possedere la dominazione — è in realtà il meno libero dei due: dipende dal riconoscimento del servo, non trasforma direttamente il mondo. Per i nostri scopi, il punto rilevante è questo: il signore dipende dall'opera del servo come effetto che ritorna su di lui come condizione. Il servo è la sedimentazione strutturale del potere del signore, e quella sedimentazione si rivolta contro chi l'ha prodotta. Il signore hegeliano è già un esempio dell'aporia del potere: la sua dominazione è condizionata da ciò che ha generato, e ciò che ha generato lo trascende.
Ma Hegel resta nell'orizzonte della lotta per il riconoscimento. L'esperienza che si deve pensare è diversa: quella di chi si sottomette volontariamente non per paura e non per ingenuità, ma perché riconosce in una volontà, in un flusso di eventi, in un potere vissuto come più grande del proprio progetto individuale, la forma del proprio destino. L'esperienza religiosa ne è l'esempio più antico e più elaborato: il mistico che si abbandona alla volontà divina — nell'Abgeschiedenheit eckhartiana (Von Abegescheidenheit, ca. 1310-13), nel fana sufico, nella kenosis cristiana — non si percepisce come schiavo ma come finalmente libero. L'abbandono trasforma l'identità: si cessa di essere soggetto separato che impone il proprio progetto al mondo, e si diviene canale attraverso cui una volontà più vasta produce effetti. Nelle forme politiche, questo meccanismo produce ciò che Eric Hoffer aveva analizzato in The True Believer (1951, parte II): il seguace del movimento di massa che si dissolve nell'identità collettiva non si percepisce come ridotto ma come moltiplicato.
Occorre però chiarire prima la struttura, poi il criterio di verifica. La sottomissione è un atto di potenza non per la postura psicologica di chi la compie, né per il suo esito contingente, ma per la sua collocazione causale: chi si sottomette autenticamente non rinuncia al proprio conatus, ma lo sposta deliberatamente dentro un circuito causale più ampio, riconosciuto come condizione di una Possibilità altrimenti inaccessibile. È, in termini archeontologici, una scelta che riguarda dove far agire la propria Possibilità — non una rinuncia ad essa. L'autenticità di questa collocazione si verifica poi con un criterio operativo: la sottomissione è un atto di potenza quando aumenta i gradi di Possibilità reale del soggetto — quando apre scenari che da solo non avrebbe potuto percorrere, quando la Realtà prodotta retroagisce ampliando la capacità di risposta al reale, non semplicemente le opzioni disponibili all'interno del sistema. Questa precisazione è necessaria: anche un sistema chiuso può moltiplicare le proprie opzioni interne — la setta offre nuove reti, nuovi ruoli, nuovi linguaggi — pur contraendo radicalmente la capacità del soggetto di rispondere a ciò che sta fuori di essa. La distinzione non è dunque tra "più possibilità" e "meno possibilità" in senso quantitativo, ma tra espansione della capacità di rapportarsi al reale e proliferazione di opzioni entro un regime di segni che sostituisce la realtà invece di aprirla. È schiavismo raffinato — la forma più pericolosa perché la meno riconoscibile — quando la Realtà prodotta chiude questa capacità: quando il soggetto impara a non sentire la chiusura invece di imparare a rispondere al mondo.
VI. Il paradosso finale: la potenza che realizza senza limitare e la gioia come indice
Rimane da affrontare quella che nella traccia è indicata come la forma in cui gli uomini avvertono qualcosa di simile alla felicità: il momento in cui l'esercizio della potenza produce sedimentazioni strutturali che non limitano ma amplificano ulteriori possibilità, che potenziano chi agisce in tutte le sue dimensioni. Ma prima di descrivere questa figura, è necessario chiarire un punto che, se lasciato implicito, espone l'intera costruzione a un'obiezione fondamentale.
Sembra paradossale: si era aperto il saggio negando che l'uomo cerchi strutturalmente la felicità, e ora si sta descrivendo una condizione che somiglia molto all'eudaimonia. Il paradosso è reale ma non è contraddizione: richiede che si distingua con precisione tra due strutture concettualmente diverse che il linguaggio comune appiattisce sotto la stessa parola. L'eudaimonismo — nelle sue forme aristoteliche, utilitaristiche e nelle loro varianti moderne — è una teleologia normativa: la felicità è il fine verso cui l'azione umana è strutturalmente orientata, il termine che dà senso al percorso. Agire è, in questo quadro, agire per la felicità. L'Archeontologia ha rifiutato questa struttura non perché neghi l'esistenza dell'esperienza della gioia, ma perché nega che essa sia il motore strutturale del desiderio: il fine reale — spesso non riconosciuto, spesso mascherato da discorsi eudaimonistici — è la potenza.
La gioia spinoziana, invece, non è una teleologia: è un indice fenomenologico. La laetitia nell'Ethica (III, prop. 11, schol.) è la consapevolezza di un passaggio a una maggiore perfezione — a una maggiore adeguatezza causale, a un aumento della propria potenza d'esistere secondo la propria natura. Non è ciò verso cui si tende: è ciò che si avverte quando la potenza si espande senza autoannullarsi. La gioia non è il fine; è il sintomo di un processo riuscito. In questo senso preciso, il momento gioioso che emerge nella sospensione dell'aporia non è un ritorno all'eudaimonismo ma la sua negazione più radicale: non si è gioiosi perché si è cercata la gioia, ma perché si è esercitata la potenza in una forma non autodistruttiva.
Questo chiarimento permette ora di descrivere con maggiore precisione la figura del potere come processo autopoietico — termine che mutuo da Maturana e Varela (Autopoiesis and Cognition, 1980) in senso esplicitamente analogico: non intendo il sistema che si riproduce mantenendo la propria organizzazione, ma il processo in cui l'agire produce le condizioni della propria espansione qualitativa. Non più il caos ontologico-operativo del potere assoluto, non più la cristallizzazione della dominazione in struttura che imprigiona, ma la potenza come flusso che, nel produrre effetti nel mondo, trasforma anche il soggetto che agisce, rendendolo capace di gesti futuri che prima non erano nella sua Possibilità. In termini archeontologici: il momento in cui Possibilità, Necessità e Realtà non si oppongono ma si alimentano reciprocamente — in cui ciò che si è creato non pone vincoli all'apertura futura ma la orienta e la potenzia.
Permane però una domanda che non può essere elusa: se la gioia si dà nella sospensione dell'aporia, e se quella sospensione è sempre instabile e sempre provvisoria, l'umano è strutturalmente condannato a un'alternanza di espansione gioiosa e ricaduta nell'aporia? E in questo caso, la gioia è un compimento dell'umano o una sua parziale negazione? La risposta che l'Archeontologia deve dare è affermativa — in quanto, per due ragioni concatenate: la sospensione è instabile perché ogni espansione di potenza ridetermina le condizioni entro cui la successiva azione si esercita; e la finitezza non si supera, si abita. L'umano è strutturalmente in questa alternanza. Ma questa non è una condanna in senso pessimistico — è la descrizione della forma dell'esistenza di un ente finito che non può identificarsi né con la quiete assoluta della beatitudine né con il caos ontologico-operativo del potere senza limite. La gioia non è il compimento dell'umano se per compimento si intende uno stato stabile e definitivo. È invece la forma più intensa in cui l'umano si sperimenta come tale: nel momento in cui la potenza si espande senza immediatamente autoannullarsi, in cui la Possibilità apre la Realtà invece di chiuderla, in cui la Necessità non è subita come costrizione ma riconosciuta come struttura della propria natura. La gioia è compimento non come fine raggiunto, ma come piena attualizzazione del modo d'essere finito — non la negazione dell'aporia, ma la sua forma più alta: quella in cui il conflitto tra potenza e limite produce qualcosa invece di distruggersi.
La conclusione che l'Archeontologia impone non è consolatoria. Il potere inteso come potenza trasformativa è la struttura del desiderio umano non per scelta contingente né per deformazione storica correggibile, ma per la costituzione di un ente che è ontologicamente sovrabbondante — la cui Possibilità, nell'umano concreto, eccede sempre la Realtà data — e che è fenomenologicamente finito — il quale sperimenta quella sovrabbondanza come urgenza, come scandalo, come spinta che incontra resistenza. Non è il nulla che cerca di colmarsi: è il pieno che cerca di espandersi, e che trova nel limite non la propria origine ma il proprio ostacolo costitutivo. Questa distinzione non indebolisce la tesi; la precisa: la potenza non nasce dal limite, ma non può non incontrarlo.
Ogni potere porta in sé la propria negazione: nel produrre effetti pone sedimentazioni strutturali; nel sedimentare si vincola; nel vincolarsi prepara la propria crisi. Il tiranno e il magnate ne sono le figure parossistiche, ma il meccanismo vale per ogni forma di volontà trasformativa a qualsiasi livello. La sottomissione volontaria al destino è una via percorribile, ma esposta al rischio della mistificazione: richiede il criterio archeontologico — espansione o contrazione della capacità reale di risposta al mondo — per distinguere il riconoscimento genuino dalla chiusura dei propri orizzonti sotto spoglie ideologiche.
Quanto alla pace: occorre restituire alla Gelassenheit heideggeriana la complessità che merita. Non è la pace come estinzione dell'istanza trasformativa — che è sempre, in qualche misura, rinuncia alla propria Possibilità — la forma più alta a cui si possa aspirare. La Gelassenheit non è quietismo: è la trasformazione qualitativa dell'agire in un modo di abitare il mondo che non cerca di saturare la Necessità con la forza, ma di risponderle con adeguatezza. Una pace che è ancora forma d'azione — non resa, ma la modalità più lucida e più esigente del rapporto con la Realtà. E tuttavia essa custodisce un paradosso che il sistema archeontologico deve assumere senza dissolverlo: praticare il lasciar-essere richiede un soggetto che la sostenga, una capacità che si può perdere, una fedeltà che si conquista ogni volta. Il che significa che anche la Gelassenheit è potenza — la potenza di chi ha abbastanza forza da non averne bisogno. Non la negazione dell'aporia del potere, ma la sua forma più alta e più sottile: quella in cui la Possibilità riconosce la Necessità non come ostacolo ma come struttura interna della propria forma, e in quel riconoscimento trova — instabilmente, provvisoriamente — la propria pace.
Il punto più fragile rimane uno, e conviene riconoscerlo esplicitamente anziché dissolverlo nella prosa: il criterio con cui si distingue la sospensione autentica dell'aporia — quella che produce gioia e espansione — dalla semplice illusione di tale sospensione, che è invece il meccanismo fondamentale delle grandi ideologie e delle grandi dipendenze. Là dove il saggio filosofico pone il criterio archeontologico — espansione della capacità reale di risposta al mondo — la vita concreta chiede qualcosa di più sottile: la capacità di discernere, nell'esperienza soggettiva del potenziamento, se si sta davvero aprendo o se si sta imparando a non sentire la chiusura. È il confine in cui la filosofia incontra ciò che potremmo chiamare il discernimento pratico dell'esperienza — non la clinica come disciplina, non la psicopatologia, ma quella forma di attenzione al reale che precede ogni tecnica e che nessuna tecnica sostituisce. Ed è forse giusto che la filosofia vi si fermi, senza pretendere di dissolverlo: non ogni limite è uno scandalo da superare. Alcuni limiti sono la forma stessa della lucidità.




