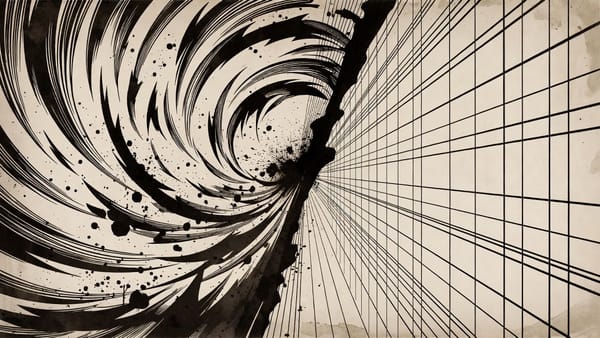Cosa non è successo nel mese di gennaio?!

Gennaio 2026 è stato un mese "normale". Normale nel senso che ci indica la nuova norma del mondo. Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela, un capo di Stato viene catturato, una capitale colpita, si parla di vittime civili. La notizia dura pochi giorni, poi scivola sotto altro. In Iran la protesta esplode, poi il Paese viene chiuso. I numeri diventano stime, le stime diventano rumore. Trentamila morti in due giorni, forse. Impossibile verificare, impossibile non andare avanti.
Negli Stati Uniti, nello stesso mese, l’agenzia anti-immigrazione uccide due civili. Le immagini mostrano che non erano un pericolo. Circolano per qualche giorno, poi spariscono dal flusso. La questione diventa “divisiva”, quindi archiviabile. Trump rilancia l’idea di prendersi la Groenlandia, minaccia dazi, riporta il controllo territoriale nel lessico politico. Un presidente europeo lo sbeffeggia, per qualche giorno sembra una farsa. Poi smette di sembrarlo. Poi torna a esserlo. La forza militare viene evocata e ritirata, ma la minaccia resta come metodo.
A Kiev manca la luce e il riscaldamento, in pieno inverno. In altri contesti lo si chiamerebbe arma di guerra; qui diventa “crisi infrastrutturale”. A Gaza circola la cifra di settantamila morti civili. Il numero non è ufficiale, ma plausibile. La precisazione diventa più importante del dato. La discussione si sposta sulla fonte, non sui corpi. Il conflitto viene tradotto in un problema di funzionamento, non di intenzione.
Nel frattempo il Mediterraneo produce il suo lessico nuovo: il ciclone Harry devasta il Sud Italia. Venti, piogge torrenziali, allagamenti. Un evento che fino a pochi anni fa sarebbe stato eccezionale, ora trattato come anomalia stagionale. A Niscemi il terreno frana. Case evacuate, paura, danni. Anche qui, nessun mistero: dissesto noto, territorio fragile, manutenzione insufficiente. Ma il disastro resta un fatto, non una domanda.
In Italia, nello stesso mese, accadono fatti apparentemente minori ma non meno rivelatori. Militanti della destra giovanile invitano gli studenti a “segnalare” insegnanti di sinistra. Non si parla di reati, ma di orientamenti. Non di fatti, ma di posizioni. L’iniziativa viene presentata come tutela della neutralità, ma assomiglia a un esercizio di delazione preventiva. Nessuno sembra davvero stupito: il linguaggio è già pronto, la pratica quasi normalizzata.
Poco dopo, uno dei sei figli del miliardario Del Vecchio diventa bersaglio pubblico non per ciò che ha fatto, ma per ciò che è. Non c’è un’accusa precisa, solo una colpa ontologica. Colpevole, forse, di essere banale: affermazioni ordinarie, trattate come rivelazioni oscene, tirate e stritolate fino a farle dire ciò che non dicono. Si discute a lungo di frasi che molti non hanno visto e che, quando le hanno viste, non hanno davvero capito. Esistere nel posto sbagliato, con il cognome sbagliato, basta. Non si critica il potere: si giudica la genealogia.
In questo quadro si colloca anche il caso Barbero. Prima la limitazione della visibilità sulle piattaforme Meta, a seguito delle sue prese di posizione sul referendum. Poi l’emergere di un errore nel manuale di Storia che porta la sua firma, nel passaggio sulle vittime del 7 ottobre. Un errore reale, corretto dall’editore, ma immediatamente letto come prova di propaganda. Nel giro di poco, Barbero viene incasellato politicamente: filo-russo, ambiguo, schierato. L’etichetta prende il posto della discussione. Non aiuta la partecipazione a un dibattito-show con Orsi, in un palazzetto, dove il registro dello storico si confonde con quello del comizio. Un po’ sembra sotto attacco, un po’ sembra usare una popolarità enorme in modo imprudente, meno rigoroso di quanto il suo ruolo richiederebbe. Ma anche qui il punto non è solo Barbero. È il meccanismo: un errore diventa identità, una posizione diventa sospetto sistemico, una figura pubblica viene ridotta a segnale politico.
Questo lessico non è neutro. È il linguaggio funzionale a un regime di verità amministrata, in cui ciò che conta è solo ciò che può essere verificato, misurato, certificato. Tutto diventa bianco o nero, 0 o 1: vero o falso, confermato o non confermato, online o offline. L’intenzione scompare, la responsabilità evapora, resta il funzionamento. È anche il linguaggio del fact-checking “rigoroso”: tecnicamente impeccabile, politicamente cieco. Non interpreta, non assume, non decide. Stabilisce solo se una frase passa o non passa il filtro. Ma quando il mondo viene ridotto a ciò che è verificabile, tutto ciò che eccede — contesto, asimmetria, violenza strutturale — diventa automaticamente “fuorviante”. Il rigore, senza volerlo, si trasforma in obbedienza semantica.
Nel frattempo muore Valentino Garavani: un fatto reale, concreto, che non polarizza. Dura un giorno. Poco prima è accaduto qualcosa di apertamente surreale: una vincitrice del Nobel per la Pace regala simbolicamente la propria medaglia a Trump. Non è un Nobel assegnato, è un gesto. Ma è proprio questo il punto: nel mondo attuale i gesti contano più degli atti, e il simbolo soppianta la responsabilità. Il fatto che una scena del genere non produca alcun corto circuito collettivo è un segnale preciso dello stato delle cose.
Quasi in silenzio, Amazon annuncia un cloud “sovrano europeo”. I telegiornali non ne parlano, i social lo ignorano. Eppure è una delle notizie più importanti del mese. La parola “sovrano” non riguarda più lo Stato, riguarda l’infrastruttura. Non il potere che decide, ma quello che rende possibile decidere. È uno dei pochi punti in cui gennaio lascia intravedere il vero asse del potere contemporaneo: chi controlla reti, flussi, dati, visibilità. Tutto il resto è superficie, rumore, amministrazione dell’attenzione.
La borsa non cresce, non crolla, oscilla. Come tutto il resto. Poi, negli ultimi giorni del mese, Microsoft perde terreno, OpenAI registra perdite significative. L’intelligenza artificiale costa moltissimo. Ma la logica resta quella americana: le perdite di oggi come investimento sulle rendite di domani. È già successo. Nel frattempo l’IA ridisegna anche il mercato dell’hardware: corsa alla RAM, prezzi in aumento, nuova scarsità artificiale.
Messo in fila, gennaio 2026 non racconta una crisi. Racconta una struttura. E un cambiamento epocale. La violenza non scandalizza, la repressione non interrompe, la minaccia non spaventa, il controllo non si vede, il territorio cede, la tecnologia si riorganizza e anticipa il futuro. Il linguaggio assorbe tutto, il tempo comprime tutto. Questo mese non è stato un’eccezione: è stato una dichiarazione di normalità.