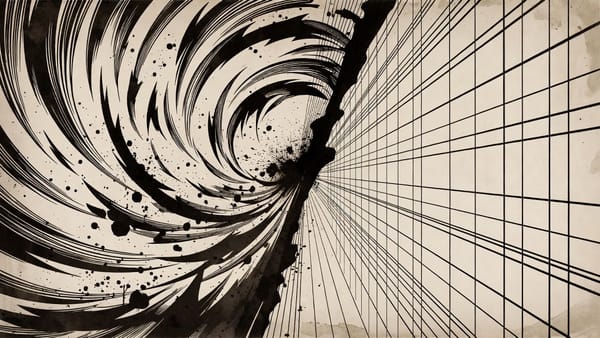Con lo zaino di cartone

Racconto
Sono arrivato a Bergamo di notte. Per la precisione novanta minuti dopo la mezzanotte. Era il 1° febbraio 1997. Erano i giorni della merla. Un freddo cane. Anche per i bergamaschi. Anche per i pastori bergamaschi. Cinque gradi sotto zero. Umidità alta. Un gelo che respiravi e che ti entrava nelle ossa.Era il secolo scorso. I treni ad alta velocità non esistevano ancora, se non per pochi ricchi, e comunque su linee ridotte.
Io ero partito da Napoli su un espresso maleodorante, nebbioso di respiri e traspiri. Gli “espressi”, o interregionali, avevano uno strano sistema di condizionamento: scompartimenti-cellette, ideati per sei passeggeri, che riuscivano nell’impresa di essere insieme caldi come un bagno turco e gelati come un’agenzia di assicurazioni in agosto. Dalle bocchette grigliate sotto i finestroni e sopra le porte poteva uscire aria caldissima o aria gelida. Senza una logica. Senza un criterio. Per un capriccio robotico.Nel frattempo la temperatura si alzava come nella più famosa grotta di Betlemme: respiri e corpi. Cappotti, sciarpe, fiato, lana bagnata.
Il calore però saliva e si concentrava in alto. Dal pavimento ai polpacci, niente. Al disotto delle ginocchia, l’Artico. Se avevi fortuna riuscivi a sollevare i piedi e poggiarli sulla seduta antistante. E questa era coperta o no da un foglio di giornale, a seconda della sensibilità e dell’educazione dell’utenza. Sopra i polpacci si creava invece un microclima semitropicale, persino ovattato nei suoni. Questo fino a quando qualcuno apriva la porta scorrevole. Allora entrava uno spiffero gelido, netto, presago di morte. Da un viaggio su un espresso italiano qualcuno ha probabilmente tratto ispirazione per i dissennatori.
I momenti peggiori. Quelli in cui il treno fermava in uno snodo importante. La motrice si arrestava e l’aria “calda”, quando lo era, cessava di esserlo. Le porte dei vagoni si spalancavano, la tramontana entrava. Si infilava negli scompartimenti adesso aperti ormai senza controllo. E in quei momenti molti abbassavano i finestrini: per cambiare aria, dicevano. Quindi, per fumare. Ma il momento peggiore era un altro. Il controllore.
Apriva la porta senza alcuna pietà. Di notte accendeva di colpo anche le luci. Fermo e ondeggiante, pretendeva di visionare e punzonare i biglietti. Minuti insopportabili. Da dietro le sue spalle il gelo veniva risucchiato nello scompartimento, per piantarsi sul viso come un calcio. Ti intorpidiva le mani. Ti spegneva i pensieri. Un brivido sorgeva alla base della nuca e scendeva lungo la colonna vertebrale per frangersi sull’osso sacro. Da lì si diffondeva nel basso ventre. Terminato il controllo, capitan treno richiudeva la porta con decisione. Allora potevamo sperare di riprendere piano piano calore. Nei treni espressi italiani la frase più pronunciata non era “Biglietti?!”. Era: “La portaaa!!”.
Superato il confine tra Lazio e Toscana il treno su cui viaggiavo divenne razzista. Nei viaggi successivi scoprii che era una costante. C’era sempre qualcuno che iniziava a parlare del cambio d’atmosfera. Ossia un diverso modo di lavorare. Era un crescendo che conduceva alla stessa conclusione: tutti i mali del paese erano colpa del Meridione fancazzista, pigro, attendista e fatalista.La maggioranza dei compagni di viaggio era composta proprio da quei meridionali. Rintanati nei cappotti e nelle sciarpe. Non proferivano parola. Né di consenso né di dissenso. Forse per antica educazione, perché a pontificare era quasi sempre un anziano, e sovente una donna. Anziana. Muti per cortesia sudista, quella che consiste nel lasciar parlare l’imbecille finché si stanca. Più banalmente, per economia: quando dai corda a un cretino la cosa va per le lunghe. Se tutto andava bene, tra Firenze e Bologna il treno smetteva di essere ostaggio del KKK. Se tutto invece andava male, qualcuno interveniva. Peggio ancora per dissentire. E in tal caso si guadagnava il tacito disprezzo degli astanti: non per torto o ragione, ma perché aveva prolungato la scena.La resilienza non l’hanno inventata Mario Draghi e la Commissione europea. È cosa antica. È una tecnica. È condensata nel vecchio andante: “Chinati giunco finché passa la piena”. Traduzione: non abboccare. Per fortuna capitava raramente.
In virtù delle mie esperienze di viaggio e di emigrante, potrei dire una cosa che non pretende di essere statistica: le peggiori tirate, su quel tema, le ho ascoltate spesso in Toscana, soprattutto nel tratto tra Chiusi-Chianciano Terme e Firenze Santa Maria Novella.
La temperatura a bordo non era l’unica cosa imprevedibile dei treni espressi. Anche l’orario di arrivo era considerato più un’ottimistica possibilità che una certezza. Chi prendeva un treno aggiungeva automaticamente venti o trenta minuti di ritardo. Se doveva arrivare puntuale a un appuntamento o non poteva perdere una coincidenza, ne aggiungeva altri. Più il viaggio era lungo, più la prudenza diventava matematica.
Partito a metà mattinata da Napoli, arrivai a Milano Centrale con due ore di ritardo. Dopo le dieci di sera, quando, all’epoca, i treni per Bergamo cessavano quasi di esistere. Il primo sarebbe partito poco prima dell’una. Invece di andare a chiedere il rimborso andai a chiedere come arrivare. Un bigliettaio al neon mi diede indicazioni molto chiare: treno per Brescia, discesa a Treviglio, coincidenza per Bergamo in quindici minuti. Feci il biglietto e corsi al treno.
Arrivato a Treviglio scesi. Poco dopo, iniziai a inveire nel buio contro quello stronzo. Perché di stronzo al neon si trattava. Non mi aveva detto un dettaglio: io sarei sceso a Treviglio Sud. La coincidenza avrei dovuto prenderla a Treviglio Ovest. Un’altra stazione, distante poco più di un chilometro. Perché un paese come Treviglio debba avere due stazioni ferroviarie a così breve distanza resta tuttora uno dei misteri insondabili della storia delle ferrovie.
Se avete vissuto in Lombardia al di fuori di Milano prima del 2010 saprete già che, appena gli uffici chiudevano e i solerti lombardi tornavano a casa a cenare, le strade si svuotavano e le insegne si spegnevano. Città e paesi somigliavano a copie sbiadite di certe pitture metafisiche o a certe fotografie, ma senza la luce che ti lascia sperare. Stare per strada a Treviglio alle undici di sera di un giorno feriale significava ritrovarsi ai confini del cosmo: buio, freddo, poche luci in lontananza, nebbia e rumore bianco di pioggia sull’asfalto. E, insieme al freddo, un pensiero mi trafisse: a quell’ora circolano in pochi. Delinquenti, spesso. E spesso meridionali. Con la conseguenza che era anche alto il rischio di incappare in una pattuglia e finire in caserma senza troppe domande.
Appena realizzai di essere sotto la pioggia lombarda nella stazione sbagliata, cercai di raggiungere l’altra. Ma avevo poco tempo. E più di dodici ore di viaggio sulle spalle. E una valigia. Non avevo navigatore, non avevo cellulare, non avevo nessuno a cui chiedere. E non c’era alcuna indicazione stradale: i trevigliesi, parsimoniosi quali erano e sono, avevano ritenuto inutile installarla. Loro lo sapevano già.
Mi incamminai per un viale alberato e semibuio. Fui fortunato: si vedeva la stazione. Arrivai e ovviamente il treno era già passato. Aspettai a Treviglio Ovest per un’altra ora lo stesso treno che avrei potuto aspettare a Milano Centrale senza fare il giro notturno dei viali trevigliesi. Infine sbarcai alla stazione di Bergamo. Poco dopo l’una e trenta.Pioveva. E a parte la pioggia, niente. Non c’era un autobus e non c’era un taxi. Neanche il radiotaxi, che da un telefono pubblico cercai di contattare. Dovevo arrivare a Monterosso, zona collinare di Bergamo. Mi sembrò che in Lombardia esistessero solo viali lunghi, scarsamente illuminati e deserti. Un bigliettaio assonnato mi disse di non aspettare lì il servizio notturno. “Vada a Porta Nuova”, dove forse — non era sicuro neanche lui — potevano passare più linee.
Percorsi un tratto del viale Papa Giovanni XXIII. Attraversai. Passò in quel momento l’unico bergamasco che non era rimasto a casa dopo le 18:30. Non avevo utilizzato le strisce pedonali in una città deserta. Mi insultò bestemmiando pesantemente. “Benvenuto a Bergamo”, mi dissi.Alla fine arrivai. A notte fonda. Suonai. Solo dopo un po’ aprirono l’Ostello e mi fecero entrare. Mi fecero subito un cazziatone. Eppure, arrivato a Milano, li avevo avvisati telefonicamente. Non avevamo i telefonini, all’epoca. Al Nord gli orari si rispettano. Non avevo voglia di fare storie. Resilienza da emigrante. Presi la chiave.Spartana, fredda nell’arredamento e nel clima. Il bagno era in comune con la stanza adiacente. Cercavo di addormentarmi ancora vestito quando da lì vidi entrare uno sconosciuto in camera. Dopo l’iniziale sconcerto, la cosa fu più chiara. Il mio vicino di stanza era un egiziano. Quasi un coetaneo, anche se sembrava avere vent’anni di più. Aveva lavorato in fabbrica appena arrivato, probabilmente in nero. Lì una pressa gli aveva schiacciato mano e polso. Cure poche e inadeguate. E quindi invalido, malato e senza lavoro. Quella notte aveva preso eccezionalmente una camera all’ostello: per lavarsi e dormire al caldo.
Era entrato da me in cerca di antibiotici e antidolorifici. Un ascesso gli deformava il viso. Io avevo dell’Aulin. Gliene diedi alcune bustine. Poi tornò nella sua camera. Lo rividi mesi dopo uscire dai bagni della stazione delle autolinee in cui dormiva. O meglio: vidi la polizia che lo spingeva fuori col suo sacco a pelo. Stava molto peggio. Più magro. E con un occhio reso opaco da un’infezione non curata.
Quella notte dormii poco e intensamente. La mattina alle cinque e trenta ero sveglio. L’ostello a quell’ora non forniva la colazione, ma cortesemente se la faceva pagare ugualmente. Una volta uscito non potevi tornare prima delle diciassette. Dalle undici alle cinque del pomeriggio l’ostello della gioventù era verboten. Perché avessero chiamato “ostello” una struttura così poco accogliente è un altro dei misteri insoluti di quel giorno.
Uscii in un buio in cui tutto era bianco di brina. L’autobus sarebbe passato alle sei. Arrivò con un leggero ritardo, superò due fermate e stazionò al capolinea — unico, perché era una linea circolare — da cui ripartì un quarto d’ora dopo. Per fare quattro chilometri e seicento metri, ci mise quasi un’ora. Era anche sabato, quando, a parte gli insegnanti, quasi nessun altro lavorava e le strade erano deserte.
Mi ritrovai alla stazione lasciata solo cinque ore prima. Lì vidi il pullman per Gazzaniga. Fermo a due metri da me. Erano le sette del mattino. Le sette, zero zero, zero zero. E l’autista aveva appena chiuso le porte, ma non era partito. Feci richiesta di aprire e farmi entrare. Rispose battendo il dito sul quadrante dell’orologio e roteando poi l’indice in aria: “Prendi quello dopo”. Stronzo.
Ingranò e partì. La prossima corsa, alle otto. Io alle otto avrei dovuto prendere servizio e il viaggio durava quaranta minuti. Prima ancora di iniziare a percepire uno stipendio, pagai cinquantamila lire di taxi per arrivare in orario a scuola.
Nei mesi successivi incontrai razzisti che non vollero affittarmi una casa perché ero napoletano. Altri che avrebbero voluto affittarmi tuguri proprio perché napoletano. Conobbi genitori di studenti che insinuarono che, come tutti i meridionali, la laurea l’avessi comprata. Mi fermò anche un maresciallo pugliese che, guardandomi dal finestrino aperto della sua volante, mi disse: “La tengo d’occhio”, la prima volta e “Buongiorno, professore, i miei ossequi” la seconda. Tanti modi di farti capire dove ero.
Quel primo febbraio conobbi anche la mia futura moglie marchigiana e — sebbene il matrimonio sia finito in divorzio — continuo a pensarlo un incontro fortunato. Incontrai belle persone, tra colleghi e studenti, e fuori scuola, per quanto una piccola città poteva permettere. Era più faticoso, ma non impossibile. Comunque più facile di oggi. E quel giorno incontrai anche Michele, tra i miei primissimi studenti bergamaschi, all’epoca adolescente, e a cui sono ancora molto affezionato.